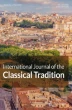References
Come sottolinea l’autrice (p. 29), il suo libro si colloca dunque nell’indirizzo “positivo” o “ottimista” dell’esegesi femminista. In particolare la James segnala (p. 244 n. 30) che, adottando la categoria di “donna elegiaca”, accoglie gli schemi della ricerca femminista poststrutturalista sull’elegia.
P. es. (pp. 122–123) il personaggio dell’amante elegiaco subirebbe la spinta di due impulsi contrapposti: la cattiva coscienza causata dalla consapevolezza della propria superiorità sessuale, economica e sociale da un lato e l’insofferenza della posizione subalterna da lui stesso accettata col servitium amoris, in contrasto con le reali gerarchie sociali. A. p. 313 n. 117 la James vede in Prop. 2.8 addirittura una sindrome di violenza apocalittica maschile, come quella riscontrata in certi omicidi moderni. Infine, in numerosi casi scopre negli elegiaci un impulso di violenza nei confronti della donna, represso, ma subconsciamente avvertito (p. es. p. 188). Non pare facile accordare questi spunti col tipo di letterarietà dell’elegia continuamente proclamato dall’autrice, che comporterebbe l’assenza in essa di sentimenti sinceramente provati.
J. N. Adams, “Latin Words for ‘Woman’ and ‘Wife’”, Glotta 50 (1972) 234–255.
Su questo verso dovremo tornare più avanti. Cf. nota 48.
Tale è certamente la puella di Hor. sat. 1.5.82.
Cf. p. es. Catull. 13, che nello stesso carme usa il termine per indicare prima una prostituta prezzolata (13.4), poi la propria donna, probabilmente Lesbia (13.11).
Cf. infatti il citato Tib. 1.5.41, dove femina è la donna nelle cui braccia il poeta cerca invano di dimenticare la sua puella (termine che appare dopo tre soli versi, in forte contrapposizione al precedente femina).
Cf. Mart. 1.64.2 e 4 (bella es, novimus, et puella, verum est, /et dives, quis enim potest negare?/ sed cum te nimium, Fabulla, laudas,/nec dives neque bella nec puella es), col commento di M. Citroni, M. Valerii Martialis Epigrammaton liber primus. Introd., testo, appar crit. e comm., Firenze 1975, 210–211 (125–126 per l’uso aggettivale di anus); inoltre Mart. 5.45.1; 8.79.5 (dove puella è contrapposto a vetulas/vetulis dei vv. 1–2); cf. 10.67.2.
Prop. 1.7.11 me laudent doctae solum placuisse puellae; 2.11.6 nec dicet: ‘cinis hic docta puella fuit’; 2.13.11 me iuvet in gremio doctae legisse puellae.
Ov. am. 2.4.17–18 sive es docta, places raras dotata per artes; /sive rudis, placita es simplicitate tua.
Ov. ars 2.281–282 sunt tamen et doctae, rarissima turba, puellae; / altera non doctae turba, sed esse volunt. Su questa distinzione ovidiana torneremo più avanti.
Ov. ars 3.329–348. Si noti che tra queste opere di poesia erotica sembra fuori luogo l’Eneide (vv. 337–338); ma molti anni più tardi, dall’esilio, Ovidio catalogherà così anche questa: trist. 2.533–536.
Cf. p. es. M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boethius. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit, München, 1994, I, 589–590; 592. La James sottolinea anche l’ascendenza comica del personaggio elegiaco della lena (p. 25) ed accosta la figura del poeta-amante al giovane innamorato della commedia (p. es. p. 20).
Non si può che essere d’accordo con lei, quando afferme che il vir, figura che compare spesso nell’elegia, non è il marito della puella, ma l’amante in carica al momento.
P. es. a p. 37, e passim.
I malconci versi che seguono fanno riferimento a celebri critici letterari. Ma vd. adesso M. Capasso, Il ritorno di Cornelio Gallo. Il papiro di Qasr Ibrîm venticinque anni dopo. Con un contributo di P. Radiciotti, Gli Album del Centro di Studi Papirologici dell’ Università degli Studi di Lecce, 5, Napoli 2003, 64–72.
Pp. 28–29. Il riferimento è al libro di P. Veyne, L’élégie érotique romaine. L’amour, la poésie et l’Occident, Paris 1983 (utilizzato dalla James nella traduzione inglese, Chicago 1988).
P. 223: “... reading elegy’s focus on her (cioè la docta puella) from her viewpoint directs readerly attention to a small but important class of women whose livelihood and social circumstances are recorded in Roman love elegy”. La non sempre netta distinzione tra universo letterario e realtà può essere simboleggiata dal circolo vizioso costituito dall’assunzione di Citeride (la Licoride di Gallo) da un lato come esempio di reale cortigiana indipendente, dall’altro come modello e prototipo della docta puella elegiaca (p. 260 n. 14).
P. 30: “... as if it were a single body of material produced more in Homeric oral-formulaic than in Alexandrian fashion”.
Vd. oltre per il significato insolito che la James assegna al termine. Qui lo uso nel senso corrente di discorso o esercizio retorico finalizzato a indurre il destinatario ad una determinata condotta.
La James definisce “impasse elegiaca” l’insolubile contrasto tra il personaggio del poeta, disposto ad offrire soltanto versi, e la puella, che pretende doni tangibili. Altrove parla di “stallo” (“stalemate”) e di “tiro alla fune” (“tug-of-war”): p. 105.
Mi riferisco a W. Stroh, Die römische Liebeselegie als werbende Dichtung, Amsterdam 1971 (cf. James, p. 246 n. 49; p. 20).
Cf. von Albrecht, op. cit., 616–617.
La James ritiene (p. 21) che le Heroides ovidiane adombrino l’inevitabile sconfitta della donna elegiaca. È un’opinione interessante, specialmente nel quadro della sua interpretazione dell’elegia ovidiana. Vd. oltre.
Vengono esclusi per questo motivo il IV libro di Properzio (p. 29) e i testi che sviluppano il tema della militia amoris (p. 288 n. 2). Il motivo dell’esclusione di Ligdamo non viene specificato. Questo autore poteva offrire un interessante campo d’indagine relativamente agli aspetti intrinsecamente legati al genere letterario.
Noteremo di passaggio l’ “insularità” anglosassone che caratterizza l’informazione bibliografica della James. Su 268 titoli elencati nelle “Secondary Sources” (pp. 324–335), solo 11, se non vado errato, sono in lingue diverse dall’inglese. Alcune opere straniere (come quella di Veyne, cf. sopra, nota 17) sono tuttavia utilizzate in traduzione.
Cf. p. es. pp. 280–281 n. 19: la donna di cui è innamorato Pontico in Prop. 1.9 per la James non può essere una schiava, perché in tal caso non ci sarebbe bisogno di persuasione sessuale poetica. La donna è invece sicuramente una schiava (cf. la pregnante opposizione del v. 4 imperat empta modo). Nella letteratura non mancano certo serve divenute padrone per motivi amorosi. Nell’antichità si può ricordare la Bissula di Ausonio e, ai tempi stessi di Properzio, Hor. c. 2.4: qui la donna possiede una virtù che tutti gli elegiaci vorrebbero nelle loro donne (v. 19 lucro aversam); e Orazio conclude assicurando il destinatario di non aver perso la testa per la bella schiava—ciò che evidentemente è accaduto al Pontico di Properzio. Un’altra forzatura è rilevabile quando la James rifiuta di prendere sul serio la pur riluttante accettazione da parte di Tibullo di amare Nemesi alle condizioni di lei: pagando (2.4.52 illius est nobis lege colendus amor). Si potrà convenire con la James (p. 90) che il ricorso all’assassinio e al sacrilegio (2.4.21–26) per procurarsi il denaro occorrente non suona credibile; ma non si vede perché il progetto di vendere la dimora paterna (2.4.53–54) debba considerarsi “a rather impractical course of action”. Quanto poi all’asserita mancanza di concrete promesse (p. 284 n. 44), l’elegia precedente (2.3.49–58) specifica i doni che Tibullo intende fare a Nemesi una volta venuto in possesso di non specificate praedae: vesti di Cos, servi indiani, porpore puniche e tirie. È avvertibile una doppia petizione di principio: poiché il personaggio del poeta è un avaro che pretende amore gratis, la sua accettazione di pagare non può essere sincera; poiché l’elegia è fondamentalmente ipocrita, non sono credibili i progetti indicati. In tal modo si finisce per far dire al testo il contrario di ciò che dice. La riprova è l’affermazione (p. 87) che Tib. 2.4 offre a Nemesi “that rarest of things in elegy—a stable, longterm marital relationship of lover and puella, in which the lover will bring gifts to his beloved’s grave after her death”. Al contrario, la promessa o il desiderio di amore eterno è un motivo topico in Tibullo (1.1.57–68; 1.5.21–34; 1.6.85–86) e in Properzio (1.12.20; 2.15.25–26; 2.6.41–42). Altrove la James ne ammette l’esistenza, pur liquidandolo come non credibile (vd. oltre). L’amore oltre la morte è anche in Prop. 2.15.36 e 4.7. Ovidio, am. 3.9 consacra il motivo, con citazione di Tib. 1.1.60.
Ma va aggiunto che il poeta elegiaco, proprio grazie ai suoi versi, può ristabilire talvolta il rapporto di sottomissione della puella: cf. Prop. 2.26.21–22 tam mihi pulchra puella/serviat.
Tali erano Volumnia-Citeride (la Licoride di Gallo) e la Delia di Tibullo (cf. 1.6.67–68); e alle liberte Ovidio si rivolge nell’Ars amatoria (3.483; 615–616).
“The fictive lover-poets of elegy aim to capitalize on that advantage by using her appreciation of poetry to gain access to her bedroom”.
Lo conferma il malizioso doppio senso di ars 2.166 verba dabam. Cf anche James, p. 282 n. 32.
Cf. sopra, nota 12. Ov. ars 3.329–348. Si noti che tra queste opere di poesia erotica sembra fuori luogo l’Eneide (vv. 337–338); ma molti anni più tardi, dall’esilio, Ovidio catalogherà così anche questa: trist. 2.533–536.
L’interpretazione (pp. 177–181) di Prop. 2.28 alla luce delle elegie ovidiane sull’aborto di Corinna (am. 2.13 e 14) mostra però come una giusta intuizione possa trasformarsi in un preconcetto, se applicata all’esegesi di un testo aprioristicamente assunto come la conferma di un postulato da dimostrare. Che nell’elegia properziana la malattia di Cinzia sia in realtà dovuta a un aborto appare come una forzatura per amor di tesi.
Sul versante maschile è sviluppato il tema dell’impotenza, che faceva una fugace comparsa in Tibullo: vd. oltre.
Ovidio “focusing so intently on disingenuity” (p. 156) rivelerebbe dunque l’ipocrisia del genere letterario rappresentando il proprio personaggio come sfacciatamente ipocrita con le donne, strizzando al contempo l’occhio al lettore.
Cf. p. es. p. 199; “the lover-poet...reveals the shallow basis of his attachment to women”.
Sul preteso “disgusto” di Ovidio per la donna “al naturale” torneremo fra poco.
Noterò di passaggio che una lettura centrata essenzialmente sulle gerarchie sociali e sessuali di Roma antica non può che portare ad una conclusione già largamente scontata: che la società romana era ingiusta. Non occorre ricordare che accanto alle cortigiane c’erano anche gli schiavi. Che nell’Ars compaiano idee “maschiliste” (p. es. che le donne desiderino essere violentate) e che in essa venga codificato lo sfruttamento sessuale della donna è indubbio; ma sarebbe strano se ciò non accadesse, data la società dell’epoca. Un giudizio storicamente fondato può essere emesso solo in rapporto ad essa.
Cf. p. es. von Albrecht, op. cit.,. Mit Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit, München 19942, I, 641.
Quando la James (pp. 205–207) interpreta ars 2.681–694; 719–732, non si potrà non essere d’accordo con lei sull’idea che per Ovidio il piacere della donna (2.683–684) sia parte integrante di quello dell’uomo (anche se forse è esagerata la sua affermazione che l’orgasmo della donna è in realtà solo un mezzo per controllarla: Ovidio rifiuta l’amore per i fanciulli perché desidera il piacere di entrambi i partner, non perché non può controllarli). E non è esatto dire (p. 205; cf. p. 317 n. 149) che l’esortazione a sbrigarsi quando c’è il pericolo di venire sorpresi (2.731–732) contraddice la sollecitudine per il piacere della donna prima raccomandata. Il ritmo lento non è necessariamente preferibile per la donna (2.725–726); la fretta quando c’è pericole è eccitante per entrambi (3.603–604). Anche nel III libro (3.793–804) il praeceptor si augura che uomo e donna raggiungano entrambi il piacere. È vero che esorta le frigide a fingere l’orgasmo (796–797), ma le commisera, a quanto sembra sinceramente (799–800). Discutendo il passo, la James (p. 209) passa sotto silenzio proprio questi versi di commiserazione per le donne frigide.
F. Jacoby, “Zur Entstehung der römischen Elegie,” Rheinisches Museum N.F. 60 (1905) 48–105 (=F. Jacoby, Kleine Schriften, II, Berlin 1961, 65–121). Neppure è citato B. Gentili, “Epigramma ed elegia”, in: L’Épigramme grecque, Entr. Fond. Hardt 14, Vandoeuvres-Genève 1967, 39–90. Sebbene, come notato (sopra, nota 22), sia utilizzato il libro sull’elegia di Stroh, manca il riferimento al suo studio sull’origine dell’elegia (W. Stroh, “Die Ursprünge der römischen Elegie. Ein altes Problem im Lichte eines neuen Fundes”, Poetica 15 [1983] 205–246). È invece presente in bibliografia, ma appena utilizzato, A. A. Day, The Origins of Latin Love Elegy, Oxford 1938.
Pp. 108–109: “But where Greek elegy grieves for, say, comrades fallen in the warfare of extramarital sexual passion, Roman love elegy laments primarily...the lover-poet’s pitiful condition” ecc.
L’accenno all’intertestualità di p. 32 riguarda solo il “dialogo” fra gli elegiaci; al massimo (p. 33) vengono considerate le Egloghe virgiliane. Un caso pressoché unico è costituito dalla nota 53, alle pp. 293–294, dove vengono registrati alcuni richiami properziani a Catullo. Per quanto riguarda Ov. ars 1.453 hoc opus hic labor est, primo sine munere iungi, l’irriverente allusione a Verg. Aen. 6.129 è rilevata, sulle orme di Hollis, a p. 316 n. 14 (ma non a p. 249 n. 69). Non viene però registrato l’impiego di un topos epico (anche virgiliano) pochi versi prima (ars 1.435–436, citato e discusso a p. 286 n. 57): non mihi sacrilegas meretricum ut persequar artes/cum totidem linguis sint satis ora decem. Omero parlava di dieci bocche, ma già l’epico latino Hostius aveva aumentato il numero a cento. Dopo l’uguale numero di Virgilio, Ovidio torna con civetteria alle dieci di Omero. Sul topos si veda F. Giancott, “Aerea vox. Un frammento attribuito da Servio a Lucrezio e consimili espressioni di altri poeti in Macrobio, Servio e altri”, in: Grammatici latini d’età imperiale, Miscellanea Filologica dell’Università di Genova. Pubbl. dell’Ist. di Filol. Class. e Mediev. XLV, 1976, 41–95. Non va perso di vista che proprio nell’Ars (3.337–338) l’Eneide viene dichiarata la vetta più alta della letteratura latina. Dissacrazione del motivo, a scopi diversi, anche in Pers. 5.1–2.
Al Gallo di Qasr Ibrîm per certi caratteri dell’elegia; a Catull. 95 per le mele lasciate cadere da Cinzia in Prop. 1.3.
Cf. sopra, nota 27, fine. Cf. p. es. pp. 280–281 n. 19: la donna di cui è innamorato Pontico in Prop. 1.9 per la James non può essere una schiava, perché in tal caso non ci sarebbe bisogno di persuasione sessuale poetica. La donna è invece sicuramente una schiava (cf. la pregnante opposizione del v. 4 imperat empta modo). Nella letteratura non mancano certo serve divenute padrone per motivi amorosi. Nell’antichità si può ricordare la Bissula di Ausonio e, ai tempi stessi di Properzio, Hor. c. 2.4: qui la donna possiede una virtù che tutti gli elegiaci vorrebbero nelle loro donne (v. 19 lucro aversam); e Orazio conclude assicurando il destinatario di non aver perso la testa per la bella schiava—ciò che evidentemente è accaduto al Pontico di Properzio. Un’altra forzatura è rilevabile quando la James rifiuta di prendere sul serio la pur riluttante accettazione da parte di Tibullo di amare Nemesi alle condizioni di lei: pagando (2.4.52 illius est nobis lege colendus amor). Si potrà convenire con la James (p. 90) che il ricorso all’assassinio e al sacrilegio (2.4.21–26) per procurarsi il denaro occorrente non suona credibile; ma non si vede perché il progetto di vendere la dimora paterna (2.4.53–54) debba considerarsi “a rather impractical course of action”. Quanto poi all’asserita mancanza di concrete promesse (p. 284 n. 44), l’elegia precedente (2.3.49–58) specifica i doni che Tibullo intende fare a Nemesi una volta venuto in possesso di non specificate praedae: vesti di Cos, servi indiani, porpore puniche e tirie. È avvertibile una doppia petizione di principio: poiché il personaggio del poeta è un avaro che pretende amore gratis, la sua accettazione di pagare non può essere sincera; poiché l’elegia è fondamentalmente ipocrita, non sono credibili i progetti indicati. In tal modo si finisce per far dire al testo il contrario di ciò che dice. La riprova è l’affermazione (p. 87) che Tib. 2.4 offre a Nemesi “that rarest of things in elegy—a stable, longterm marital relationship of lover and puella, in which the lover will bring gifts to his beloved’s grave after her death”. Al contrario, la promessa o il desiderio di amore eterno è un motivo topico in Tibullo (1.1.57–68; 1.5.21–34; 1.6.85–86) e in Properzio (1.12.20; 2.15.25–26; 2.6.41–42). Altrove la James ne ammette l’esistenza, pur liquidandolo come non credibile (vd. oltre). L’amore oltre la morte è anche in Prop. 2.15.36 e 4.7. Ovidio, am. 3.9 consacra il motivo, con citazione di Tib. 1.1.60.
Il motivo è ripreso anche da Tibullo: 1.8.68 (per Marato innamorato: et tua iam fletu lumina fessa tument) e 2.6.43 (per Nemesi: nec lacrimis oculos digna est foedare loquaces).
È possibile che sia presente anche una reminiscenza di Cornelio Gallo: il motivo del nome dell’amata inciso sulla corteccia degli alberi. Prop. 1.18.19-22 ricorda infatti Verg ecl. 10.53-54, che forse riprende Gallo.
Ov. 2.13.19-21 (tuque, laborantes utero miserata puellas,/quorum tarda latens corpora tendit onus, /lenis ades, precibusque meis fave, Ilithyia) richiama con evidenza Hor. c. 3.22.2-3 (quae laborantis utero puellas/ter vocata audis adimisque leto) e c. saec. 13–14 (Rite maturos aperire partus,/lenis Ilithyia, tuere matres). Si noti la sfrontatezza con cui le espressioni oraziane vengono impiegate per chiedere la protezione della dea dei parti per una donna che ha abortito.
Cf. IG XIV 769 (p. 210)=W. Peek, Griechische Vers-Inschriften, Band I. Grab-Epigramme, Berlin 1955, 1883 (p. 570), v. 6: τί \(\tau \rho \upsilon \gamma \alpha \overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\frown}$}}{\iota } s\) őμφακαs ήλικίν;... Lygd. 5.19 quid fraudare iuvat vitem crescentibus uvis?; Ov. am. 2.14.23 quid plenam fraudas vitem crescentibus uvis? Nell’epigramma funebre greco e in Ligdamo il riferimento è alla morte prematura, in Ovidio all’aborto. Non intendo entrare nella complessa questione dei rapporti tra Ligdamo e Ovidio. Noterò solamente che ha torto J. C. McKeown, Ovid: Amores. Text, Proleg. and Comm. In four volumes, III: A Commentary on Book Two, Leeds 1998, 305, nel ritenere non appropriato al contesto il distico 5.19-20 di Ligdamo. L’immagine dei frutti acerbi doveva al contrario essere riferita in origine alla morte prematura, come mostra l’epigramma. È stato Ovidio a adattarla all’aborto.
Si ricordi anche che in am. 1.14 Ovidio afferma di aver dissuaso Corinna dal tingersi i capelli.
In un solo caso (p. 206) si quò parlare di goffaggine dovuta ad eccessiva letteralità: Ov. ars 2.720 non obstet tangas quo minus illa pudor, reso con “no modesty interferes, by which you are less allowed to touch them”. Inoltre obstet è congiuntivo, non indicativo, e quo non è un pronome relativo. Non obstet ... quo minus vale “non impedisca” di toccare.
Cf. anche McKeown. op. cit., Ovid: Amores. Text, Proleg. and Comm. In four volumes, III: A Commentary on Book Two, Leeds 1998, III, 90.
Altrove (p. 118) la James cita Tib. 1.8.67 con un ametrio desinas al posto di desistas.
Cf. M. Janka, Ovid Ars amatoria. Buch 2. Kommentar, Heidelberg 1997, 401.
Cf. Janka, op. cit., Ovid Ars amatoria. Buch 2. Kommentar, Heidelberg 1997, 472: “von ihnen schon dann Lust verspürt ist, wenn sie nicht kunstvoll stimuliert werden”.
Così traduce R. K. Gibson, Ovid. Ars Amatoria Book 3. Ed. with Introd. and Comm., Cambridge 2003, 402. Aggiungerò che in Ov. ars 2.285 il vigilatum carmen, più probabilmente che un paraclausithyron (così James, p. 203), sarà una poesia composta in una veglia notturna, secondo una lunga tradizione: cf. Janka, op. cit., Ovid Ars amatoria. Buch 2. Kommentar, Heidelberg 1997, 234–235.
Poetria è anche in Cic. Cael. 64 L’altra forma, poetris, è impiegata da Pers. chol. 13 proprio in contrapposizione al maschile poeta: corvos poetas et poetridas picas.
Cf. S. Costanza, Tertulliano, De pallio. Testo, trad. e comm., Collana di studi classici 3, Napoli 1968, 126.
Solo l’aggettivo suasorius può riferirsi alla pars deliberativa di un’orazione (cf. Quint. 3.8.6).
Cf. nota 20. Vd. oltre per il significato insolito che la James assegna al termine. Qui lo uso nel senso corrente di discorso o esercizio retorico finalizzato a indurre il destinatario ad una determinata condotta.
K. Quinn, “The Poet and his Audience in the Augustan Age”, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt/Rise and Decline of the Roman World (ANRW) II 30, 1, ed. W. Haase (Berlin/ New York 1982) 153.
Serv. ad ecl. 6.11 dicitur autem ingenti favore a Vergilio esse recitata, adeo ut, cum eam postea Cytheris cantasset in theatro ... stupefactus Cicero, cuius esset, requireret. Et cum eum tandem aliquando vidisset, dixisse dicitur et ad suam et ad illius laudem ‘magnae spes alltera Romae’ (Aen.) 12.168): quod iste postea ad Ascanium transtulit, sicut commentatores loquuntur.
Un paio di esempi: i Curiazi erano albani, non etruschi (come detto a p. 228); Coridone e Alessi compaiono nella II egloga di Virgilio, non nella III (come affermato a p. 242 n. 15).
Ho restituito la forma italiana antica al posto di “degli” della James.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Setaioli, A. L’amore egoista. A proposito di un libro americano sull’elegia augustea. Int class trad 10, 243–258 (2003). https://doi.org/10.1007/s12138-003-0010-4
Issue Date:
DOI: https://doi.org/10.1007/s12138-003-0010-4